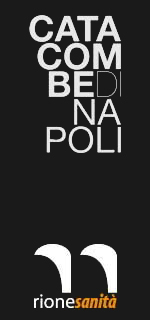Autore: Antonio Nazzaro
Autore: Antonio Nazzaro
Titolo: Irpinia ombelico d’Italia
Sottotitolo: Geografia geologica-territori-itinerari
Descrizione: Volume in formato 16° (cm 19,5 x 13); 190 pagine.
Luogo, Editore, data: Napoli, Giannini, 2017
Collana:
ISBN: 9788874318728
Prezzo: Euro 22,00
Disponibilità: In commercio
All’altezza del 41° parallelo l’Irpinia attraversa l’Appennino compresa tra due vulcani, il Vulture e il Vesuvio. All’incanto delle marine che tanto affascinano il turista isolan-costiero, questo libro contrappone un entroterra sconosciuto, figlio di altri antichi mari, che hanno lasciato i loro fondali pietrificati nelle colline e nelle montagne di un paesaggio che va innanzitutto connotato per la sua intrinseca matrice geologica.
In questa prospettiva viene analizzata in modo sistematico la geografia irpina, aggiungendovi numerosi rimandi di storia materiale, lungi dalle vicende di feudatari e signori di castelli nefasti, avanzo di un pauroso passato, come furono definiti i manieri irpini.
Emergono allora i tesori nascosti di una regione che già Virgilio poneva al centro dell’Italia riferendosi alla Valle d’Ansanto, dove si manifestano fenomeni di assoluta unicità scientifica. Di questo entroterra, troppo spesso avvertito come un letto di Procuste da cui fuggire, si delineano quindi attrattive inattese, tali da indurre a progetti di vita lontani dalle linee guida di chi, per afferrare la palla che rimbalza continuamente davanti a sè, si comporta come la farfalla notturna attratta dalla luce che l’accecherà.
INDICE
Prologo 7
PARTE I
INTRODUZIONE GEOLOGICA 11
Preludio 12
Le pietre e il paesaggio 13
Geografie provvisorie 14
L’Irpina e il suo Appennino 16
PARTE II
ANATOMIA DELL’IRPINIA 25
Le Unità Morfologiche Territoriali 26
Montagne 29
Capitolo 1
I Monti Parteni 31
Il tridente dei monti Parteni 31
La dorsale settentrionale del Monte Vergine-Monti di Avella 33
La valle del Clanio-Acqualonga 35
Il Santuario di Montevergine e un itinerario montano 37
La dorsale centrale dei Monti Pizzone e Arciano 39
Da Nola a Forino, il Vallo di Lauro 42
La dorsale meridionale del Pizzo d’Alvano 43
Le rocce dei monti Parteni 44
Capitolo 2
I Monti Picentini 45
L’orgoglio degli Appennini 45
Il gruppo occidentale del Monte Mai 48
La Civita di Ogliara e la miniera del Monte Pizzaùtolo 49
Il gruppo centrale del Monte Terminio 52
La Piana del Dragone e la traversata del Terminio 53
Il gruppo orientale del Monte Cervialto 57
Attraverso il Piano del Gaudo 58
Un paleosuolo del Cretaceo 59
Un lago pleistocenico 60
Le rocce dei monti Picentini 62
Colline e Altopiani 65
Capitolo 3
Valli e colline del Sabato e della Solofrana 69
Limpido corre 69
Il Fenestrelle, la Dogana del Grano e i pioppi del principe 72
Il Passo Serra, i merletti di Montefusco, il Panopticon 77
La Basilica di Capo la Torre e lo Specum Martirum 80
Calzolai, fabbri, ramiere e fonderie 81
Il Serro di Montoro, Passo Turci, Francesco Solimena 82
Le rocce 85
Capitolo 4
Valle e colline del Calore 87
Lungo il 15° meridiano 87
Tra i paesi della valle 90
Le rocce 94
Le rocce piroclastiche dell’Irpinia occidentale 95
Tufare e Catacombe 97
Capitolo 5
Dorsale Centrale di Frigento 103
Migliano e Carmasciano 103 L
e Mefite d’Ansanto 104
Mirabella Eclano, Frigento e il paleolitico di Pietraliscia
108 Le rocce 109
Il basalto della via Appia 111
Capitolo 6
Valle dell’Òfanto, il Formicoso e le Serre 113
Un altopiano tra gli spartiacque 113
Il semicerchio dell’ Òfanto 115
L’abbazia del Golèto 117
Un Parco Sismologico ad Aquilonia 118
Lungo la dorsale di Monteverde 119
Le rocce 123
Capitolo 7
Valle dell’Ùfita, l’ Arianese e la Baronia 125
Un triangolo di fiumi 125
Ariano Irpino, la Starza e il Museo di Palazzo Anzani 128
Le pietre del castello, un sekòmata, la spiaggia di San Sossio 129
Le rocce 132
Capitolo 8
Alto Cervaro 136
Gli Altopiani del Regio Tratturo 136
I vulcani di fango delle Bolle della Malvizza 138
Le rocce 140
Capitolo 9
Sella di Conza e Alto Sele 141
Un varco tra Tirreno e Adriatico 141
Conza, Ronza e Travagliuso 142
Il Museo dell’Acqua e la Benedizione delle Sementi 142
Senerchia e l’oasi della Valle della Caccia 143
Le rocce 144
PARTE III
APPENDICI
LE STRADE 149
In breve 149
Strade per viaggiare 150
Strade per conoscere 151
La Via Regia delle Puglie e la statale 90 151
La statale 403 del Vallo di Lauro 151
La statale 88 dei Due Principati 152
Lungo i valichi dei monti Picentini 152
La strada provinciale 138 152
La statale 164 delle Croci di Acerno 153
La statale 91 del Fondo valle Sele 153
Strade interne 153
La statale 303 del Formicoso 153
La statale 400 di Castelvetere 154
Strade borboniche 154
La statale 374
Irpina Ferdinandea 154
La strada di Melfi 154
La ferrovia irpina 156
I paesi 157
Le colonne crucifere 158
Fontane di lavandaie e fontane di viandanti 158
VESUVIO IN IRPINIA 159
TERREMOTI IN ITALIA MERIDIONALE 164
Glossario 169
Note e bibliografia 173
Indice dei nomi 181
PROLOGO
Certo che no. Oggi nessuno si sognerebbe di dire che l’Irpinia è addirittura il centro dell’Italia. Ma un tempo ci fu qualcuno, Virgilio, che lo scrisse nel suo celebre poema, riferendosi alle Mefìte d’Ansanto: ...est locus Italiae medio. Laddove una piaga della terra ancora soffia gas mortiferi, c’era una volta un tempio frequentato da folle di pellegrini che vi si recavano per celebrare i defunti all’altare della dea eponima.
Quel fiato sotterraneo, che la potenza infera emanava nascosta nel sotterraneo abisso di quel bulicame, vinceva in un seducente deliquio chi vi si avvicinava, traendolo a sè. Ancora oggi nell’alta valle del Frèdane gorgoglia da millenni quella fanghiglia, che contiene, come la scienza ha dimostrato, anidride carbonica in quantità superiore a qualsiasi altro posto non vulcanico del pianeta, deducendo che quell’alito è alimentato dagli infuocati magmi del mantello terrestre. Eppure, al turista isolancostiero questo luogo straordinario resta ignoto. Ed anche a molti di coloro che considerano l’Irpinia come una terra di mezzo, da attraversare da una sponda all’altra della penisola, mentre quell’Italiae medio ci ricorda invece che ne è il baricentro. Raggiunta, come si racconta, da uomini fieri che vi pervennero guidati da un lupo (hirpus in osco) totemico, l’Irpinia li accolse ricca dei frutti di una terra resa fertile dalle ceneri eruttate dai vulcani di cui Napoli potentemente si adorna. Quelle del Vesuvio, che formano un mantello sul quale si spandeva una vegetazione tanto estesa e lussureggiante da rendere l’Irpinia universamente nota come verde, e quelle dei Campi Flegrei della gigantesca eruzione dell’Ignimbrite Campana, compattate in grandi spessori di tufo che fu poi scavato in grotte, sepolcreti, rifugi e catacombe. Per contro, i territori vulcanici napoletani ricevevano in cambio già 2000 anni fa le acque delle sue sorgenti generose, come quelle che alimentavano l’acquedotto di Serino, il cui percorso è ancora visibile a tratti, ai Ponti Rossi di Napoli o ad Agnano. L’acqua dei monti Picentini riforniva così la flotta romana ormeggiata a Miliscola, attinta ad una cisterna lunga 50 metri, larga 20 ed alta 12,con 49 pilastri suddivisi in 5 navate. Simile a una cattedrale sotterranea, la Piscina Mirabile è ancora lì come un tempo, sulla sua altura a picco sul mare.
Come provincia di Avellino l’Irpinia attraversa l’Appennino all’altezza del 41° parallelo lungo una striscia alta massimo 60 km tra Greci e Senerchia e lunga circa 85 km compresa tra due vulcani, il Vulture sulla sponda orientale dell’Òfanto, e il Vesuvio che quasi tocca a Domicella, presso Palma Campania. Esamineremo questa regione dal punto di vista geologico, analizzandone la topografia con i suoi fiumi, le valli, i monti, e proponendone una suddivisione in settori omogenei che definiamo Unità Morfologiche Territoriali. Verranno così alla luce territori dei quali spesso non si pronunzia più neanche il nome, riferendosi ad essi semplicemente con i termini di Alta, e, talvolta, persino, Bassa Irpinia. Accenneremo inoltre ad alcuni aspetti delle condizioni materiali che caratterizzavano l’esistenza degli uomini che vivevano, un tempo in gran numero, in que ste contrade di montagna, nel cui àmbito venivano soddisfatte gran parte delle loro esigenze, e che poi l’avrebbero abbandonata, sradicandovi il proprio destino. Una storia materiale dell’Irpinia che si affermi tra le superfetazioni di storie di feudi e di diocesi esistenti in giro, arricchirebbe di contenuti autentici una nuova relazione con un entroterra spesso percepito come luogo della mancanza e dell’abbandono, ma del quale potrebbero essere còlte ricchezze insospettate, tali da orientare progetti di vita in armonia con se stessi, lontani da contesti urbani spesso alienanti e dalle linee guida di un’esistenza legata ad una modernità che sembra destinata a non afferrare mai la palla che lascia rimbalzare continuamente davanti a sè. Penso infatti che la prospettiva geologica offrirebbe lo spunto a considerare questa regione nella sua essenza, illustrando il significato delle pietre, degli affioramenti rocciosi, della forma delle montagne o delle valli, e di ciò che ne abita il suolo, che sia un albero, un bosco, o un vecchio paese. In questo modo si apprezzerebbe il valore culturale del paesaggio, riconoscendone di conseguenza il valore ambientale. Sarebbe come scoprire e recuperare tesori nascosti nei sotterranei di un museo e metterli in mostra traendo da essi motivo non solo di godimento estetico e intellettuale, ma anche di risorse economiche attraverso nuove e più consapevoli forme di turismo e di fruizione delle bellezze naturali che offre il Museo della Natura. A questo proposito sarà istruttivo prendere nota che su 159 pagine della Guida generale della Regione Campania del 2005 soltanto 12 sono dedicate all’Irpinia, e 35, su 676, nella Guida della Campania del Touring Club Italiano. Sfogliando poi la guida del Club Alpino Italiano all’Appennino Meridionale nella collana dei Monti d’Italia, ci accorgeremmo che solo 67 pagine su 600 sono dedicate agli splendidi monti del Partenio e dei Picentini. Così stando le cose, spero che questo libro contribuisca ad spostare verso i territori interni un pò dell’interesse rivolto esclusivamente ai più noti siti costieri. Territori interni sì, ma non tanto, dato che distano da 50 a 100 kilometri dalla costa.
NOTA Quando si fa la storia delle rocce e quindi si parla della loro origine e delle trasformazioni che subirono insieme a quelle dell’ambiente in cui di volta in volta si trovarono, bisogna scordarsi i calendari che scandiscono i tempi degli uomini e le periodizzazioni della loro storia, che comprende appena una manciata di migliaia di anni, ridicolmente breve rispetto ai milioni di anni che servono per fare la storia delle pietre. Non si parlerà quindi di medioevo, di rinascimento e così via, ma di cretaceo,
giurassico, e tutti gli altri nomi inusuali del calendario geologico che indicano periodi di tempo infinitamente più lunghi, fino a coprire l’intera età del nostro Pianeta di 4 miliardi e 600 milioni di anni. Ma, tranquillizziamoci, nel nostro caso ci fermeremo a circa 250 milioni di anni fa. Le mappe e gli schizzi geografici nel testo hanno carattere schematico, secondo un criterio definito topologico da un autorevole geografo (2). La cartografia di riferimento è quella dell’Istituto Geografico Militare che si consiglia vivamente, almeno alla scala 1:100.000 (per dettagli maggiori si possono consultare le carte al 50.000 e al 25.000). Sono in parte disponibili le carte geologiche dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Si è cercato di utilizzare termini geologici il cui significato può trovarsi in qualsiasi buon dizionario italiano. Per una escursione geologica occorrerebbe, oltre alla carta geologica (quando disponibile), un dispositivo G.P.S., un taccuino per appunti, un binocolo e una lente di ingrandimento (per vedere fossili o minerali) ed eventualmente, usando ogni precauzione, un boccettino di acido cloridrico con contagocce, per distinguere le rocce calcaree dalle altre.Abbreviazioni: M.a. (m.a.) = milioni di anni fa .........
Valli e colline del Sabato e della Solofrana 69
Limpido corre 69
Il Fenestrelle, la Dogana del Grano e i pioppi del principe 72
Il Passo Serra, i merletti di Montefusco, il Panopticon 77
La Basilica di Capo la Torre e lo Specum Martirum 80
Calzolai, fabbri, ramiere e fonderie 81
Il Serro di Montoro, Passo Turci, Francesco Solimena 82
Le rocce 85
Capitolo 4
Valle e colline del Calore 87
Lungo il 15° meridiano 87
Tra i paesi della valle 90
Le rocce 94
Le rocce piroclastiche dell’Irpinia occidentale 95
Tufare e Catacombe 97
Capitolo 5
Dorsale Centrale di Frigento 103
Migliano e Carmasciano 103 L
e Mefite d’Ansanto 104
Mirabella Eclano, Frigento e il paleolitico di Pietraliscia
108 Le rocce 109
Il basalto della via Appia 111
Capitolo 6
Valle dell’Òfanto, il Formicoso e le Serre 113
Un altopiano tra gli spartiacque 113
Il semicerchio dell’ Òfanto 115
L’abbazia del Golèto 117
Un Parco Sismologico ad Aquilonia 118
Lungo la dorsale di Monteverde 119
Le rocce 123
Capitolo 7
Valle dell’Ùfita, l’ Arianese e la Baronia 125
Un triangolo di fiumi 125
Ariano Irpino, la Starza e il Museo di Palazzo Anzani 128
Le pietre del castello, un sekòmata, la spiaggia di San Sossio 129
Le rocce 132
Capitolo 8
Alto Cervaro 136
Gli Altopiani del Regio Tratturo 136
I vulcani di fango delle Bolle della Malvizza 138
Le rocce 140
Capitolo 9
Sella di Conza e Alto Sele 141
Un varco tra Tirreno e Adriatico 141
Conza, Ronza e Travagliuso 142
Il Museo dell’Acqua e la Benedizione delle Sementi 142
Senerchia e l’oasi della Valle della Caccia 143
Le rocce 144
PARTE III
APPENDICI
LE STRADE 149
In breve 149
Strade per viaggiare 150
Strade per conoscere 151
La Via Regia delle Puglie e la statale 90 151
La statale 403 del Vallo di Lauro 151
La statale 88 dei Due Principati 152
Lungo i valichi dei monti Picentini 152
La strada provinciale 138 152
La statale 164 delle Croci di Acerno 153
La statale 91 del Fondo valle Sele 153
Strade interne 153
La statale 303 del Formicoso 153
La statale 400 di Castelvetere 154
Strade borboniche 154
La statale 374
Irpina Ferdinandea 154
La strada di Melfi 154
La ferrovia irpina 156
I paesi 157
Le colonne crucifere 158
Fontane di lavandaie e fontane di viandanti 158
VESUVIO IN IRPINIA 159
TERREMOTI IN ITALIA MERIDIONALE 164
Glossario 169
Note e bibliografia 173
Indice dei nomi 181
PROLOGO
Certo che no. Oggi nessuno si sognerebbe di dire che l’Irpinia è addirittura il centro dell’Italia. Ma un tempo ci fu qualcuno, Virgilio, che lo scrisse nel suo celebre poema, riferendosi alle Mefìte d’Ansanto: ...est locus Italiae medio. Laddove una piaga della terra ancora soffia gas mortiferi, c’era una volta un tempio frequentato da folle di pellegrini che vi si recavano per celebrare i defunti all’altare della dea eponima.
Quel fiato sotterraneo, che la potenza infera emanava nascosta nel sotterraneo abisso di quel bulicame, vinceva in un seducente deliquio chi vi si avvicinava, traendolo a sè. Ancora oggi nell’alta valle del Frèdane gorgoglia da millenni quella fanghiglia, che contiene, come la scienza ha dimostrato, anidride carbonica in quantità superiore a qualsiasi altro posto non vulcanico del pianeta, deducendo che quell’alito è alimentato dagli infuocati magmi del mantello terrestre. Eppure, al turista isolancostiero questo luogo straordinario resta ignoto. Ed anche a molti di coloro che considerano l’Irpinia come una terra di mezzo, da attraversare da una sponda all’altra della penisola, mentre quell’Italiae medio ci ricorda invece che ne è il baricentro. Raggiunta, come si racconta, da uomini fieri che vi pervennero guidati da un lupo (hirpus in osco) totemico, l’Irpinia li accolse ricca dei frutti di una terra resa fertile dalle ceneri eruttate dai vulcani di cui Napoli potentemente si adorna. Quelle del Vesuvio, che formano un mantello sul quale si spandeva una vegetazione tanto estesa e lussureggiante da rendere l’Irpinia universamente nota come verde, e quelle dei Campi Flegrei della gigantesca eruzione dell’Ignimbrite Campana, compattate in grandi spessori di tufo che fu poi scavato in grotte, sepolcreti, rifugi e catacombe. Per contro, i territori vulcanici napoletani ricevevano in cambio già 2000 anni fa le acque delle sue sorgenti generose, come quelle che alimentavano l’acquedotto di Serino, il cui percorso è ancora visibile a tratti, ai Ponti Rossi di Napoli o ad Agnano. L’acqua dei monti Picentini riforniva così la flotta romana ormeggiata a Miliscola, attinta ad una cisterna lunga 50 metri, larga 20 ed alta 12,con 49 pilastri suddivisi in 5 navate. Simile a una cattedrale sotterranea, la Piscina Mirabile è ancora lì come un tempo, sulla sua altura a picco sul mare.
Come provincia di Avellino l’Irpinia attraversa l’Appennino all’altezza del 41° parallelo lungo una striscia alta massimo 60 km tra Greci e Senerchia e lunga circa 85 km compresa tra due vulcani, il Vulture sulla sponda orientale dell’Òfanto, e il Vesuvio che quasi tocca a Domicella, presso Palma Campania. Esamineremo questa regione dal punto di vista geologico, analizzandone la topografia con i suoi fiumi, le valli, i monti, e proponendone una suddivisione in settori omogenei che definiamo Unità Morfologiche Territoriali. Verranno così alla luce territori dei quali spesso non si pronunzia più neanche il nome, riferendosi ad essi semplicemente con i termini di Alta, e, talvolta, persino, Bassa Irpinia. Accenneremo inoltre ad alcuni aspetti delle condizioni materiali che caratterizzavano l’esistenza degli uomini che vivevano, un tempo in gran numero, in que ste contrade di montagna, nel cui àmbito venivano soddisfatte gran parte delle loro esigenze, e che poi l’avrebbero abbandonata, sradicandovi il proprio destino. Una storia materiale dell’Irpinia che si affermi tra le superfetazioni di storie di feudi e di diocesi esistenti in giro, arricchirebbe di contenuti autentici una nuova relazione con un entroterra spesso percepito come luogo della mancanza e dell’abbandono, ma del quale potrebbero essere còlte ricchezze insospettate, tali da orientare progetti di vita in armonia con se stessi, lontani da contesti urbani spesso alienanti e dalle linee guida di un’esistenza legata ad una modernità che sembra destinata a non afferrare mai la palla che lascia rimbalzare continuamente davanti a sè. Penso infatti che la prospettiva geologica offrirebbe lo spunto a considerare questa regione nella sua essenza, illustrando il significato delle pietre, degli affioramenti rocciosi, della forma delle montagne o delle valli, e di ciò che ne abita il suolo, che sia un albero, un bosco, o un vecchio paese. In questo modo si apprezzerebbe il valore culturale del paesaggio, riconoscendone di conseguenza il valore ambientale. Sarebbe come scoprire e recuperare tesori nascosti nei sotterranei di un museo e metterli in mostra traendo da essi motivo non solo di godimento estetico e intellettuale, ma anche di risorse economiche attraverso nuove e più consapevoli forme di turismo e di fruizione delle bellezze naturali che offre il Museo della Natura. A questo proposito sarà istruttivo prendere nota che su 159 pagine della Guida generale della Regione Campania del 2005 soltanto 12 sono dedicate all’Irpinia, e 35, su 676, nella Guida della Campania del Touring Club Italiano. Sfogliando poi la guida del Club Alpino Italiano all’Appennino Meridionale nella collana dei Monti d’Italia, ci accorgeremmo che solo 67 pagine su 600 sono dedicate agli splendidi monti del Partenio e dei Picentini. Così stando le cose, spero che questo libro contribuisca ad spostare verso i territori interni un pò dell’interesse rivolto esclusivamente ai più noti siti costieri. Territori interni sì, ma non tanto, dato che distano da 50 a 100 kilometri dalla costa.
NOTA Quando si fa la storia delle rocce e quindi si parla della loro origine e delle trasformazioni che subirono insieme a quelle dell’ambiente in cui di volta in volta si trovarono, bisogna scordarsi i calendari che scandiscono i tempi degli uomini e le periodizzazioni della loro storia, che comprende appena una manciata di migliaia di anni, ridicolmente breve rispetto ai milioni di anni che servono per fare la storia delle pietre. Non si parlerà quindi di medioevo, di rinascimento e così via, ma di cretaceo,
giurassico, e tutti gli altri nomi inusuali del calendario geologico che indicano periodi di tempo infinitamente più lunghi, fino a coprire l’intera età del nostro Pianeta di 4 miliardi e 600 milioni di anni. Ma, tranquillizziamoci, nel nostro caso ci fermeremo a circa 250 milioni di anni fa. Le mappe e gli schizzi geografici nel testo hanno carattere schematico, secondo un criterio definito topologico da un autorevole geografo (2). La cartografia di riferimento è quella dell’Istituto Geografico Militare che si consiglia vivamente, almeno alla scala 1:100.000 (per dettagli maggiori si possono consultare le carte al 50.000 e al 25.000). Sono in parte disponibili le carte geologiche dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Si è cercato di utilizzare termini geologici il cui significato può trovarsi in qualsiasi buon dizionario italiano. Per una escursione geologica occorrerebbe, oltre alla carta geologica (quando disponibile), un dispositivo G.P.S., un taccuino per appunti, un binocolo e una lente di ingrandimento (per vedere fossili o minerali) ed eventualmente, usando ogni precauzione, un boccettino di acido cloridrico con contagocce, per distinguere le rocce calcaree dalle altre.Abbreviazioni: M.a. (m.a.) = milioni di anni fa .........