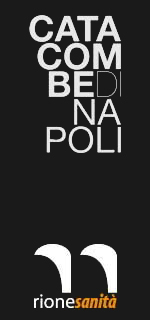Autore: Ottaviano De Biase
Autore: Ottaviano De BiaseTitolo: L'acqua del Serino
Sottotitolo: Sorgenti e Acquedotti
Prefazione di Francesco Barra
Edizione fuori commercio
Descrizione: Volume in 8° (cm 24 x 17); 224 pagine; illustrazioni in b/n nel testo
Luogo, Editore, data: pubblicazione a cura della Comunità Montana Serinese - Solofrana, 2006
Disponibilita': NO
L’ampia, appassionata e documentata ricerca di Ottaviano De Biase ricostruisce la storia dell’alta valle del Sabato, vista attraverso le millenarie vicende degli acquedotti che l’attraversavano. E’ questa sicuramente una chiave privilegiata di lettura e d’interpretazione, che parte dall’habitat naturale e dalle strutture produttive dell’area. Difatti, l’analisi dei requisiti ambientali vale assai spesso a porre in rilievo le costanti del divenire storico.
Sin dalla più remota antichità, la valle del Sabato ha costituito una via naturale di prim’ordine tra l’Irpinia e il Sannio, oltre ad essere punto di transito obbligato per il passaggio dal Napoletano e dal Salernitano verso la Puglia e l’Alta Irpinia.
Il fiume ha inoltre sempre rappresentato, sia pure per motivi diversi, una risorsa non trascurabile per la popolazione, nelle età più antiche per la pesca, poi per l’irrigazione dei campi, ed infine, grazie allo sfruttamento della copiosa energia idraulica, per l’alimentazione di mulini e di numerosi altri opifici protoindustriali (ferriere, ramiere, gualchiere). Ben diversa dall’attuale - va del resto ricordato - era nel passato la portata del Sabato, drasticamente ridotta nella seconda metà del XIX secolo dalla quasi completa captazione delle sue sorgenti a beneficio dell’acquedotto di Napoli. La natura e la geografia hanno quindi efficacemente concorso nel determinare alcuni requisiti essenziali della storia dell’alta valle del Sabato.
L’Acquedotto di Napoli (detto comunemente ma erroneamente del Serino, quando andrebbe se mai denominato del Sabato) trae origine dai progetti redatti dopo l’Unità da un valente tecnico della Campania, l’ing. Felice Abate, per il ripristino dell’antico acquedotto augusteo della Campania (che superava in galleria il valico della Laura, tra Forino e Montoro), come s’ipotizzava sin dal XVI secolo; ma fu alla fine prescelto un progetto alternativo, che ricalcava il tracciato dell’acquedotto romano di Benevento lungo la valle del Sabato. Nel 1874 il Comune di Napoli stipulò la convenzione per la concessione dell’opera alla società inglese The General Credit and Discount Company, e il 7 novembre di quello stesso anno chiese al governo che fosse dichiarata la pubblica utilità dell’opera e venisse autorizzato l’esproprio delle sorgenti Urciuoli. Le opposizioni prodotte dalle province di Avellino e di Benevento e dai Comuni della valle del sabato furono respinte dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici il 5 febbraio 1877, ma l’opera prese avvio solo nel 1882, ricevendo particolare impulso dopo il colera di Napoli del 1884, ad opera della nuova società The Naples Water Works Company Limited. Nel 1921, infine, vennero captate anche le sorgenti Acquaro e Pelosi.
L’opera, di altissimo livello tecnico e di enorme valore per la vita di Napoli e dei centri della Campania costiera, arrecÚ tuttavia assai scarsi benefici all’Irpinia, i cui Comuni non godettero di allacciamenti alla condotta idrica che pur attraversa il loro territorio, mentre nel contempo si produceva una drastica riduzione della portata del sabato, con conseguente riduzione dell’energia motrice per i mulini e gli altri opifici e della stessa acqua per l’irrigazione.
L’attenta ricostruzione condotta sul lungo periodo da Ottaviano De Biase di queste complesse e tormentate vicende tecniche e giuridico-amministrative, e della loro ricaduta sulle popolazioni del Serinese e della valle del Sabato, consente di ripercorrere un capitolo quanto mai significativo della storia del Mezzogiorno d’Italia.
Francesco Barra